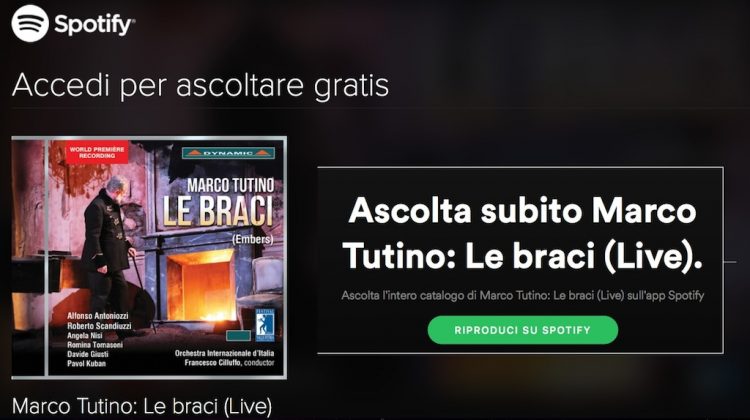“Ho scelto una storia che non solo fosse ben articolata drammaturgicamente, ma che ci raccontasse, ci appartenessee, ci descrivesse”. Così, a chiosa di una personalissima introduzione al suo ultimo lavoro operistico, Le braci, commenta Marco Tutino, il compositore già autore di una lunga serie di lavori per il teatro, tra cui Vite immaginarie, La lupa, Il gatto con gli stivali e Senso: “Le braci nascono come una sfida – prosegue il compositore – (…) decido di provare una missione quasi impossibile: mettere in scena un apparentemente banale e classico ‘triangolo’ sentimentale e nello stesso tempo incaricarlo di rappresentare la caduta di un impero”. L’impero in questione è quello austro-ungarico e la vicenda, andata in scena ieri sera presso il Teatro dell’Opera di Firenze, è infatti ambientata in una Vienna a cavallo fra tempi e periodi molto distanti tra loro: due amici, Konrad ed Henrik, si incontrano dopo 44 anni, ormai anziani, per riportare alla memoria le vicende che li hanno traghettati verso una lunga e dolorosa separazione.
I continui flashback dei due protagonisti strappano il passato alla sua eterna quiete per riportarlo, non cronologicamente ma per pura associazione di idee, al centro della scena, in una scenografia, firmata da Tiziano Santi, sapientemente divisa a metà: ai due lati l’esterno in cui ebbe luogo la fatidica caccia, quella che i due rimembrano e che continua ad arrovellare i pensieri di Henrik; al centro l’interno del castello nel quale lo stesso Henrik ha trascorso, senza alcun contatto con l’esterno e la sola compagnia di Nini, la governante novantenne, i suoi ultimi venti anni di vita. Un monologo, sostenuto dall’intera orchestra, precede però la messinscena: Leo Muscato legge Ultime braci, testo del Sándor Márai già autore de Le braci, l’omonimo romanzo dal quale Tutino ha tratto il libretto dell’opera. L’orchestra si inserisce a monologo già iniziato, con un velocissimo e bollente fraseggio su di una scala cromatica discendente. In piano, pianissimo, con suoni gravi agli ottoni, la musica inizia a commentare le parole del monologo che prosegue in salita, con pathos sempre crescente. Un linguaggio che ricorda lo Strawinsky della Sagra, laddove i fiati irrompono con veloci e spezzati fraseggi che aggiungono pennellate di colore, schizzi nevrotici su tappeti di archi in registro acuto.